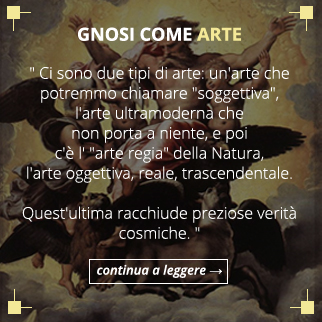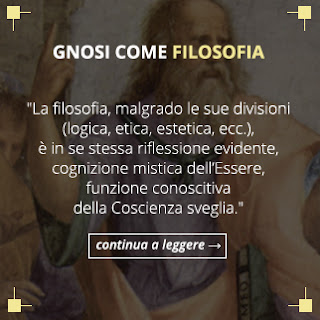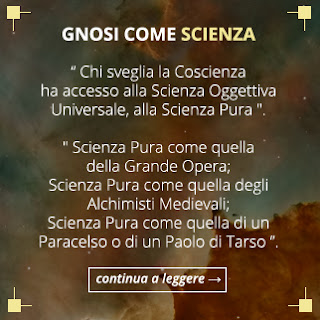Ecco un altro motivo perché serve l'informazione in presenza e non nel labirinto online. Molto di più se si tratta di argomenti di Gnosi, spiritualità, ecc. che richiedono la pratica e guida esclusivamente e sempre in presenza, soltanto così c'è contatto da coscienza a coscienza.Chi pensi di poter avere una piccola informazione online su cosa propone la Gnosi, l'unico che avrà è disinformazione, sia su pagine web, video o altro.
Esempio, qualsiasi video di Internet si dilunga intenzionalmente e non va direttamente al tema del suo titolo, ma intenzionalmente si prolunga e alla fine il suo messaggio svanisce nel nulla… In molti casi avviene così, per varie ragioni:
La più comune si chiama “Clickbait”, una pratica che cerca di ottenere il massimo numero di interazioni possibile, poiché la piattaforma in cui si trova il video pagherà all'autore del video una somma in denaro per ogni interazione o click. Ciò si ottiene mettendo al video un titolo molto pretenzioso, affinché nell’internauta si generi un’aspettativa sul contenuto del video,sufficiente per sceglierlo all’interno dell'ampia offerta esistente sulla rete su ogni tema. Evidentemente, quelle aspettative poi vengono deluse, però l'obiettivo ormai è stato raggiunto. Questo oggi è stato perfezionato, mettendo immagini di impatto all'inizio, nei primi secondi del video, per attirare l'attenzione.
L'altra ragione è che per mettere dei canali sulla rete, le piattaforme di solito vanno “a peso”, che tradotto nel linguaggio digitale implica che l’autore del canale carichi contenuti costantemente. Come tutto nella vita, non sempre si ha qualcosa da dire. Ho visto persone che si sono scusate per non aver caricato un video sulle piattaforme per una settimana di fila. Così è la tirannia digitale, che spinge gli stessi creatori dei contenuti a dare di più, a qualsiasi prezzo. Questo li porta a chiedere ispirazione alle "intelligenze" artificiali che in pochi minuti sono capaci di generare un testo su qualsiasi tema. È evidente che l’autore del video, con la pressione che riceve e la fretta, non verifica se l’IA ha gettato fumo negli occhi o ha fatto degli errori di bibliografia, ecc. L'ho verificato personalmente quando ho interrogato l'intelligenza artificiale in merito a diversi temi che conoscevo bene e gli errori sono tremendi, purtroppo in mezzo a dati che invece sono veri. Perciò stai peggio di prima, se poi non ti prendi il disturbo di verificare personalmente e all'antica ciò che viene detto. Come ho detto, questi creatori hanno già il loro testo generato con l’IA, pieno di ovvietà e genericità, se non con errori, con cui producono il video.
L'ultima ragione, che in fondo è alla base delle due precedenti, è l’ignoranza. Ignoranza sul tema che viene trattato e, come ho detto, motivata dalla semplice pressione di generare contenuti.
Questo va di male in peggio giacché ormai queste tecniche fra i giovani non hanno successo, perché non si può “cacciare sempre con la stessa trappola”. Adesso sono diventati popolari i video brevi, di grande impatto in poco tempo, benché con gli stessi problemi di inesattezze e testi generati dall’IA, ma condivisi su molte piattaforme che impongono limiti di tempo ai video, come Instagram, TikTok, ecc. Non è invece il caso di YouTube che per la sua voracità pubblicitaria preferisce video lunghi. È evidente però che in questo modo è difficile approfondire qualsiasi tema.
In tutto ci sono eccezioni ed è vero che ci sono persone che hanno dei master sui temi che trattano, per esperienza personale, accademica, ecc. e producono contenuti decenti, ma sono pochi.